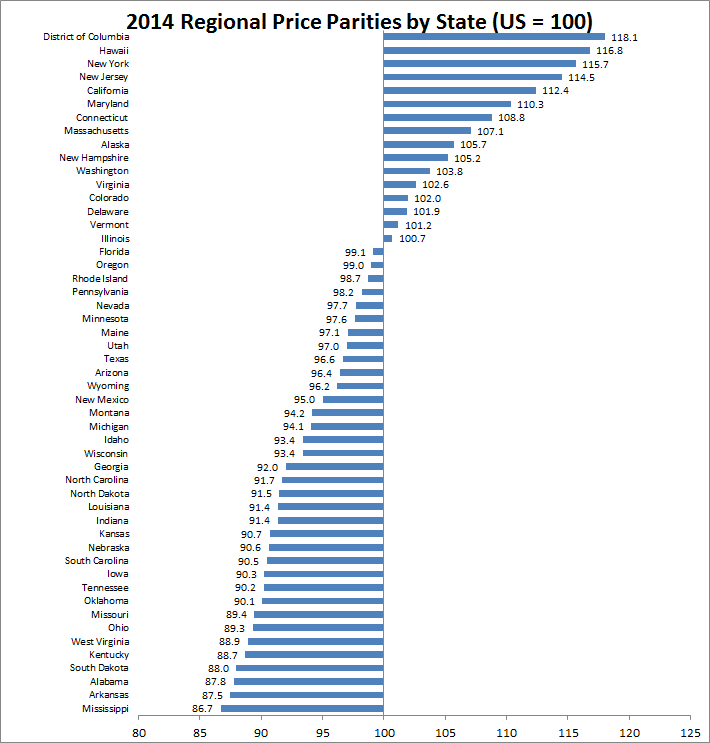A: «Senti un po’, ma secondo te la matematica e la fisica sono cultura? Intendo, non “cultura” nel senso di sinonimo di conoscenza, ma cultura intesa come bagaglio di nozioni e principi che determinano l’identità di un popolo o di un gruppo.»
B: «Beh, sì, esiste una storia della matematica e della fisica, come esiste una storia dell’arte, popoli diversi che in epoche diverse sono stati determinati dalla scienza.»
A: «Okay, ma quello è il passato, oggi qualsiasi scoperta importante in ambito fisico è fatta da gruppi di scienziati che rappresentano ogni parte del globo e quando un matematico dimostra un teorema, nel giro di millisecondi la sua scoperta diventa patrimonio dell’umanità grazie a Internet. Diresti mai che il web è britannico come il suo creatore o svizzero come il posto in cui è stato fisicamente creato?»
B: «Okay, in questo senso la fisica e la matematica oggi non costituiscono più l’identità di un popolo, ma costituiscono comunque l’identità dell’umanità.»
A: «Però voglio spingermi oltre: facendo un ragionamento platonico, i concetti della matematica in qualche modo prescindono da questa umanità. Se un cataclisma globale producesse un reboot del genere umano, con una nuova generazione di esseri senzienti che iniziano la loro esperienza dalle caverne e dalle clave, nel giro di qualche millennio arriverebbero comunque alle nostre medesime conclusioni. Magari il linguaggio dei simboli che userebbero per rappresentare le idee sarebbe diverso dal nostro o l’ordine delle scoperte alterato, ma anche se vivessimo su continenti fatti in modo diverso, prima o poi inventerebbero un sistema geometrico basato sugli stessi assiomi di quella che noi chiamiamo “geometria euclidea” e in quel sistema una forma costituita da tre segmenti uniti tra di loro alle estremità formerebbe tre angoli complessivamente pari ad un angolo piatto. Parimenti per la fisica, scoprirebbero il numero di Avogadro e le altre costanti fondamentali, anche se gli darebbero altri nomi.»
B: «Okay, quindi?»
A: «Per la letteratura o la musica non è così: se tutta la nostra cultura andasse perduta, chi verrebbe dopo non saprebbe mai dei sonetti di Shakespeare o se trovasse un reperto archeologico che gli consentisse di riascoltare la nona di Beethoven, potrebbe considerarla un terribile frastuono. I concetti della matematica e della fisica sono talmente universali che non possiamo considerarli un elemento identitario, perché qualsiasi civiltà in grado di elaborare una logica non contraddittoria la cui forma deriva dalla struttura stessa dell’universo arriverebbe alle medesime conclusioni.»
B: «Va bene, diciamo che i concetti della matematica, pur essendo conoscenze non sono cultura nel senso identitario del termine. Perché vuoi stabilire questa distinzione?»
A: «Tutto nasce da una domanda: qual è il senso dell’apprendimento? Vorrei però escludere da questo ragionamento la matematica e le altre scienze il cui scopo è rappresentare lo stato delle cose nell’universo: fisica, chimica, biologia e affini. Per queste discipline, il senso dell’apprendimento non è messo in discussione: si tratta di conoscenza della realtà pura e semplice. Il fatto che sia universale elimina qualsiasi necessità di un giudizio di valore. Pure se io fossi solo nell’universo e rinunciassi a tutta la mia storia passata, la conoscenza della logica e della scienza mi darebbero potere sul mondo.»
B: «Okay, è un ragionamento un po’ superficiale, dal momento che la scienza affonda le radici nella filosofia, quantomeno per l’aspetto epistemologico, ma diciamo per semplicità che mettiamo da parte matematica e scienze e il relativo bagaglio metodologico. Cosa rimane? Letteratura, storia, arte?»
A: «Sì, perché ci interessa apprenderle?»
B: «Beh, pensa alle pitture rupestri preistoriche: l’arte è stata una necessità dell’uomo ben prima della matematica.»
A: «Certo, l’istinto della creatività è innegabile, in tutte le sue forme. Tuttavia, creare e apprendere sono due fenomeni in qualche modo slegati: conosco persone che nonostante un decennio di lezioni settimanali di storia dell’arte, non saprebbero produrre nemmeno le pitture rupestri della caccia ai bisonti.»
B: «Una parte del tempo speso ad apprendere serve a darci delle competenze, degli strumenti per orientarci nella società. In questo senso utilitaristico, l’apprendimento della cultura umanistica ci trasmette dei simboli e delle tecniche che usiamo per relazionarci con gli altri.»
A: «Vero, ma nemmeno questo obiettivo vorrei mettere in discussione. Tuttavia noi italiani spendiamo nell’apprendimento circa un quinto della nostra vita. Non sono convinto che tutto il tempo speso serva solo per trasmetterci delle competenze sociali. Se questo fosse l’unico obiettivo, bisognerebbe criticarne aspramente il metodo: qual è l’utilità relativa di aver appreso il motivo per cui si dice “il pomo della discordia” e mille altre frasi desuete e magari non capire una parola di Cinese?»
B: «Infatti c’è una discussione pubblica sul fatto che i programmi d’istruzione non tengano il passo con la modernità e col fatto che la cultura si sta globalizzando con un’accelerazione tale che è difficile tenere il passo, dato un sistema di evoluzione culturale basato sulla sedimentazione e sul pensionamento delle generazioni precedenti. Se ti ricordi, qualche mese fa abbiamo letto un articolo di Claudio Giunta che si lamentava dell’inutile nozionismo letterario.»
A: «Sì, ma io penso che quei programmi siano così costruiti non per una svista. Al liceo si studia Lucrezio e non i Monty Python (e anzi si snobba apertamente la cultura pop), anche se finito il liceo le opportunità di conversare di Lucrezio sono piuttosto modeste, per non dire inesistenti, a meno che uno non sia uno di quegli intellettuali con la erre moscia, la casa ai Parioli e l’abbonamento a Micromega. Tutto sommato i miei colleghi che hanno fatto l’istituto tecnico non conoscono il De Rerum Natura (o hanno fatto il liceo, ma quel giorno erano assenti/dormivano/cazzeggiavano col telefono) eppure vivono benissimo lo stesso.»
B: «Okay, ma tu che lo conosci, ne faresti a meno?»
A: «Certo che no, ma è il medesimo fenomeno secondo cui, una volta assaggiato un vino pregiato, non ci si accontenta più del vino del discount. Da questo punto di vista, tutto l’impianto dell’apprendimento umanistico è un gigantesco sistema di creazione di clienti dell’industria culturale che, per carità, sono contento che fatturi e aumenti il PIL, ma come dice Raffaele Ventura, se la gente mette su famiglia a quarant’anni anziché a venti, perché tutto l’apparato culturale è un mega schema di Ponzi in cui gli insegnanti di lettere producono principalmente aspiranti insegnanti, non mi sembra così sostenibile. Il 99% dei soggetti che apprendono cultura in questo senso ristretto diventano semplicemente fruitori più esigenti, ma non producono nulla, o comunque ciò che hanno appreso non li aiuta a produrre contenuti migliori. Non sarebbe più semplice far studiare storia solo a quelli che intendono fare gli storici di mestiere?»
B: «Ma infatti in molte parti del mondo è così, la specializzazione inizia molto prima. Qui in Italia siamo molto legati al concetto che la cultura serve a formare dei cittadini consapevoli.»
A: «Ora mi dovresti spiegare che consapevolezza civica si raggiunge grazie a Petrarca. Non era meglio una lettura di Armi, Acciaio e Malattie?»
B: «Se qualcuno non ti aiuta a comprendere la bellezza della letteratura italiana, come puoi pensare di essere attrezzato per difenderla dal suo naturale decadimento? Vedi che gira gira, torniamo a Lucrezio?»
A: «Un po’ autoreferenziale: perché dovrei difendere la letteratura italiana e non quella francese? Il giudizio di valore non dovrebbe prescindere dalla partigianeria nazionalista?»
B: «Guarda che neppure la cultura francese potrebbe prescindere da Petrarca.»
A: «Forse Petrarca non è l’esempio adatto. Sicuramente nella mia storia scolastica sono stato misurato su decine di opere dimenticabilissime. Comunque, c’è una cosa che non mi torna.»
B: «Cosa?»
A: «Che quando ho iniziato a studiare, mi hanno detto che studiare apre la mente, che grazie all’infarinatura di quelle dieci materie, avrei imparato a pensare.»
B: «Embé? Non è così?»
A: «Forse. Una cosa che ho imparato è che un fenomeno non si giudica dal singolo caso. Mi guardo intorno, leggo le statistiche, le intenzioni di voto, gli status su Facebook e la storia che mi raccontano è un po’ diversa: gente che è uscita dal circuito dell’istruzione negli ultimi 10 anni con voti stellari, gente che sembrava veramente cazzuta nei temi sulla rivoluzione francese, e oggi condivide contenuti nello spettro che intercorre tra “al rogo gli zingheri” e “non siamo mai stati sulla Luna”.»
B: «Insomma, il Paese reale.»
A: «Sai quel modo di dire, sull’allievo che supera il maestro? A me pare che il fallimento dell’istruzione sia che non punta a produrre allievi che superino i maestri. Se tutto quello che la scuola è in grado di produrre è infarinatura per gente motivata unicamente dal voto, rimandando la polpa allo studio specialistico, essa non può considerarsi allo stesso tempo produttrice di menti consapevoli.»
B: «Beh, non occorre essere onniscienti per essere menti consapevoli.»
A: «Ti dico come la penso: il mondo della cultura è una piramide: alla base della piramide ci sono gli schiavi che fanno il lavoro pesante. Pensa al tuo lavoro in archivio, digitalizzare documenti, confrontare, tradurre, analizzare, accorpare, riassumere, collegare migliaia di informazioni, la maggior parte delle quali ininfluenti per la vita culturale della nazione. Più in alto si sale con la piramide e più incontriamo persone che grazie alla carriera e alla notorietà sfruttano il lavoro dei sottostanti per produrre analisi di alto livello, divulgazione, partecipazione a quei consessi in cui si cerca di condizionare la società.
Rispetto alla conoscenza vera e propria, la società riceve una forma digerita e semplificata (leggi: ridotta) che è come il bagliore rifratto nella grotta platonica. Tutto ciò funzionava finché c’era un criterio di fiducia, ossia: la società, che non è in grado di elaborare un pensiero autonomo in quanto sprovvista di materia prima (la conoscenza), si fida del fatto che chi è specializzato in quella funzione lo faccia per suo conto.»
B: «Quindi secondo te l’idea del cittadino consapevole è una chimera.»
A: «Certo che lo è, ma non perché lo dico io, è una semplice questione di logica, o di teoria dell’informazione, se vogliamo. Walter Lippmann c’era già arrivato nel ’22: in Public Opinion scrive che un essere umano non ha la capacità di conoscere il mondo leggendo un giornale al giorno nel metrò. Oggi al posto della carta c’è Facebook o Repubblica.it, ma il concetto è identico. Il fenotipo grillino non è altro che la dimostrazione di cosa succede in una comunità specializzata quando, parafrasando San Paolo, le mani dicono alla testa “non abbiamo bisogno di te”.»
B: «Mi stai dicendo che visto che tanto ci dobbiamo fidare, non ha senso studiare?»
A: «Sto facendo una congettura: secondo me il divario in termini di consumo culturale tra i professionisti del settore e il resto della popolazione è molto più elevato in Italia che in Svezia o in altre nazioni dove c’è un approccio più pragmatico all’istruzione, intesa come volksausbildung e non come fenomeno elitario sulla base del quale classificare la società. Inoltre, altrove la produzione culturale non è così sbilanciata in favore dell’elite culturale. In questo senso, una larga fetta di coloro che sono specializzati nel ruolo di catena di trasmissione tra i produttori della conoscenza e la società, docenti in primis, stanno fraintendendo il proprio ruolo.»
B: «In che senso?»
A: «Analizzo il comportamento delle persone. Nel comportamento di molti insegnanti riconosco uno schema: la frustrazione come malattia professionale. Una frustrazione che deriva dall’essere stritolati dal modello stesso di società che essi stessi hanno contribuito a costruire.
Mi spiego meglio: nella società contadina in cui si è affermato il ruolo del maestro come figura retribuita dalla tasca pubblica, esso incarnava l’autorevolezza. Con tale fardello sulle spalle, gli insegnanti hanno diffuso i principi illuministici della cittadinanza consapevole e della necessità di autonomia di pensiero delle società liberali. Ora che tale traguardo si sta realizzando, si rendono conto di aver segato il ramo su cui erano appollaiati. E questo crea tensioni, nervosismo, nevrosi. Trattare il resto della comunità da somari impenitenti, quando non esplicitamente mentecatti, è ormai una cifra stilistica. È tutto un continuo far notare che “no, la tua ricerca su wikipedia non vale quanto il mio PhD”.»
B: «Insomma, sotto sotto è una scontrosa richiesta di fiducia.»
A: «Già, ma purtroppo non si può guadagnare la fiducia pretendendola. Gli insegnanti hanno educato intere generazioni all’esercizio cartesiano del dubbio e oggi vorrebbero ripristinare una società classista in cui è la casta degli eruditi che detta il protocollo. Ricordo un articolo di qualche settimana fa che parlava esplicitamente di “tentazione di addomesticare la democrazia”. Altrove, dove il docente è approdato ad un ruolo più compatibile di facilitatore culturale, queste frizioni sono molto meno marcate. Non è un caso che invece in Italia fenomeni di snobismo culturale come il grammar-nazismo e la fossilizzazione linguistica siano ipertrofici.»
B: «D’altro canto l’arrabbiatura è comprensibile: in Italia sono fortemente sottopagati.»
A: «Il fatto è che la società liberale misura il valore dai risultati più che dall’impegno, e se depuriamo i risultati dall’inflazione dei voti, i risultati sono miseri. Il patto era che le arti del trivio e del quadrivio avrebbero prodotto cittadini consapevoli, ma questo impellente bisogno di riacquistare autorevolezza è la prova evidente del fallimento delle scelte educative. La maggior parte dei personaggi che hanno incarnato il ruolo storico di liberi pensatori erano degli outsider: sono diventati famosi per questo. Al contrario, il dubbio elevato a sistema produce antivaccinisti.
Nell’Italia odierna, la correlazione tra censo e risultati scolastici è ancora fortissima, una dimostrazione di più che la scuola non sta facendo la differenza. Incrementare le retribuzioni in queste condizioni, forse non se ne rendono conto, vuol dire espellere dal mercato del lavoro un buon 40% di insegnanti non qualificati.»
B: «Va bene, ma quindi cosa proponi?»
A: «Onestamente, non ho una ricetta, potrebbe essere troppo tardi per correggere la rotta, tuttavia di una cosa sono sicuro: gli insegnanti e gli altri attori culturali pagati con denaro pubblico, quando sono frustrati, sono un cancro da estirpare. Mi dispiace se sono vittime di questo burn-out collettivo, ma questo circolo vizioso della sfiducia va interrotto e lo snobismo culturale è tossico per la convivenza civile. Finché svolgeranno una funzione sociale così cruciale per la vita democratica del Paese, finché saranno lo strumento chiave per la realizzazione del progetto culturale egalitario di Condorcet, hanno una responsabilità sociale come i magistrati, responsabilità che non si ferma una volta timbrato il cartellino d’uscita.»